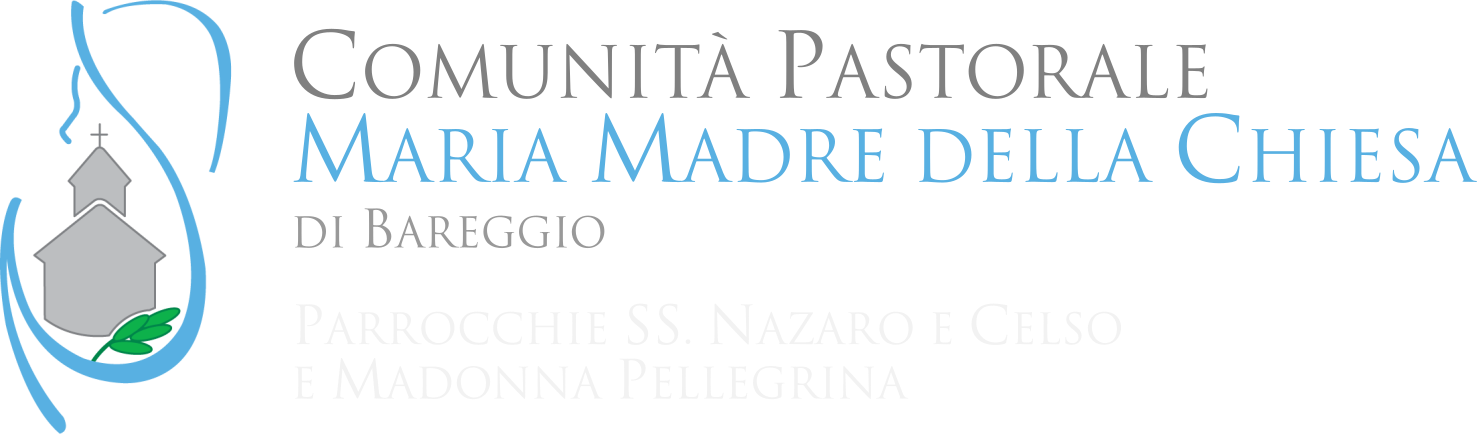Da Fidei Donum a infermiere. La testimonianza di don Giuseppe
Intervista a don Giuseppe Morstabilini
prete-infermiere in tempo di epidemia
a cura di Riccardo Galeazzi
 Lo scorso Ottobre abbiamo salutato Don Giuseppe Morstabilini – coadiutore presso i nostri oratori dal 2004 al 2012 -, a seguito della sua decisione di partire Missionario nello Zambia. Per prepararsi adeguatamente al nuovo incarico, Don Giuseppe ha poi trascorso alcuni mesi in Irlanda e avrebbe dovuto iniziare la Missione il prossimo 3 Giugno, ma i suoi piani sono stati sconvolti dalla terribile pandemia che sta ancora affliggendo tutto il mondo. Tornato dall’Irlanda però non è rimasto ad aspettare il nuovo biglietto aereo; si è rimboccato le maniche e si è dato da fare in una maniera un po’ inconsueta per un sacerdote… Gli abbiamo telefonato e gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa è successo.
Lo scorso Ottobre abbiamo salutato Don Giuseppe Morstabilini – coadiutore presso i nostri oratori dal 2004 al 2012 -, a seguito della sua decisione di partire Missionario nello Zambia. Per prepararsi adeguatamente al nuovo incarico, Don Giuseppe ha poi trascorso alcuni mesi in Irlanda e avrebbe dovuto iniziare la Missione il prossimo 3 Giugno, ma i suoi piani sono stati sconvolti dalla terribile pandemia che sta ancora affliggendo tutto il mondo. Tornato dall’Irlanda però non è rimasto ad aspettare il nuovo biglietto aereo; si è rimboccato le maniche e si è dato da fare in una maniera un po’ inconsueta per un sacerdote… Gli abbiamo telefonato e gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa è successo.
«Mi trovavo in Irlanda quando in Italia c’è stato il primo caso ufficiale di Covid-19, a Codogno. Io ho alcuni amici che lavorano nell’ospedale di Codogno e uno in particolare faceva parte di quel gruppo di personale che è rimasto blindato dentro la struttura, perché poteva essere potenzialmente infettivo. Ricordo di aver scambiato con lui e con sua moglie diversi messaggi ed entrambi erano molto preoccupati, in parte per la salute di Oscar – il mio amico – in parte perché si stava preparando la crisi che da lì a pochi giorni sarebbe poi esplosa. In quel momento il virus non era ancora arrivato in Irlanda e l’ombra di questo spettro si rifletteva sui quotidiani, dai quali apprendevo che il nostro Paese aveva un gran bisogno di tutte le professioni sanitarie che c’erano a disposizione. All’inizio di Marzo la situazione è talmente degenerata che dall’Irlanda son dovuto tornare -le scuole e gli aeroporti iniziavano a chiudere in tutta Europa. Ora risiedo a Samarate senza incarichi parrocchiali e nelle due settimane di quarantena previste per chi rientra dall’estero, guardavo i telegiornali e seguivo l’impennata che i contagi stavano avendo. Erano le prime settimane di Marzo, quelle più difficili, per intenderci. In questo contesto mi sono chiesto cosa potessi fare per rendermi utile. Sentendo vari amici e conoscenti, qualcuno mi ha chiesto: “Perché non torni a darci una mano?” Prima di entrare in Seminario, io ero un infermiere. Tutt’ora ho una qualifica valida e riconosciuta dallo Stato. Certo, erano tanti anni che mancavo dalla corsia, ma c’era un tale bisogno che chiunque, con un minimo di esperienza, sarebbe stato utile. Così, in accordo con i miei superiori, ho contattato l’ospedale di Busto Arsizio, qui, al confine con Samarate. Nel mio immaginario, pensavo che sarei finito come volontario all’ingresso, con in mano il termo-scanner. Ma c’era necessità di personale nel reparto di infettivologia, quello con i malati di Covid. Nel giro di 48 ore mi sono riscritto all’albo professionale, ho fatto un colloquio ed ero in corsia. Ho riflettuto molto con la dirigenza riguardo la mia assenza dal campo; siamo arrivati ad un accordo, un periodo di prova per vedere se fossi ancora in grado di esercitare la professione. Mi hanno affiancato un’infermiera esperta, quella che di solito di si occupa di istruire gli infermieri universitari, e dopo alcuni giorni di servizio e di studio, avevo rispolverato le tecniche apprese prima del Seminario e recuperato le conoscenze che mi mancavano. Adesso è un mese e mezzo che lavoro lì.
Io sono un prete e continuo la mia vita da prete – prego, recito il breviario, celebro messa – e se anche da qualche punto di vista il mio ministero potrebbe sembrare altro, in realtà prete e infermiere non sono in contrasto tra loro. Così come quando ero impegnato in parrocchia portavo nelle mie preghiere la vita dell’oratorio, gli incontri che avevo fatto e le intenzioni che mi venivano affidate, oggi porto il dolore dei malati, le fatiche dei miei colleghi, le difficoltà delle famiglie, il dramma di chi non ce l’ha fatta.
 Nel reparto io non entro in veste, sono lì come infermiere. Però i miei colleghi sanno che sono un sacerdote; i pazienti ogni tanto mi chiedono una benedizione e purtroppo qualche volta mi è anche capitato di essere chiamato per dare un’estrema unzione. Nell’ospedale di Busto ci sono due cappellani, ma generalmente non entrano nei reparti Covid. Con me c’è anche un altro prete, Don Fabio, che prima dell’Ordinazione era un medico a Legnano. Anche lui si è rimboccato le maniche e ha riindossato il camice.
Nel reparto io non entro in veste, sono lì come infermiere. Però i miei colleghi sanno che sono un sacerdote; i pazienti ogni tanto mi chiedono una benedizione e purtroppo qualche volta mi è anche capitato di essere chiamato per dare un’estrema unzione. Nell’ospedale di Busto ci sono due cappellani, ma generalmente non entrano nei reparti Covid. Con me c’è anche un altro prete, Don Fabio, che prima dell’Ordinazione era un medico a Legnano. Anche lui si è rimboccato le maniche e ha riindossato il camice.
Nell’ultimo periodo ho fatto questa riflessione: se dovessi tornare indietro nel tempo, alla ricerca delle radici della mia vocazione, direi che il Signore mi ha chiamato più dai letti dell’ospedale, che dal campo da calcio dell’Oratorio. Perché nel rapporto coi malati capivo che queste persone si ponevano delle domande che andavano “oltre”. Mi spiego meglio: la loro vita chiedeva risposte che andavano aldilà del bisogno di salute. Ricordo che da giovane, quando avevo il tempo, mi fermavo a scambiare due parole con i pazienti e i loro interrogativi si potevano sempre ricondurre al grande Senso della vita. E lì, in questo contesto, io ho deciso di mettere in gioco la mia esistenza in quell’orizzonte che aiuta la gente a trovare Il Senso della vita in Dio: il prete.»
A questo punto è nata spontaneamente una domanda: “Don Giuseppe, ma tu sei sicuro di voler ancora partire per l’Africa?” E lui ci ha risposto così…
«Sì, per adesso c’è bisogno di me qui e qui rimango, ma appena ci sarà la possibilità di partire per lo Zambia, partirò. La lettura che do io alla mia situazione attuale è diversa. È come se Dio, in un momento di grande svolta nella mia vita – il lavoro pastorale in Africa sicuramente non sarà come quello in Italia -, avesse voluto riportarmi alle origini della mia vocazione e in qualche modo volesse rafforzare la mia chiamata.»